 |
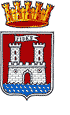 Livorno
è una città della Toscana, capoluogo
della provincia omonima. Situata lungo la costa del
Mar Ligure, Livorno è uno dei più importanti
porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico,
centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte
le città toscane, è solitamente ritenuta
la più giovane, sebbene nel suo territorio
siano presenti testimonianze storiche di epoche remote
sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda
guerra mondiale. La città, sviluppatasi a partire
dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici,
è celebre per aver dato i natali apersonalità
di prestigio come Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni
e Carlo Azeglio Ciampi. In passato, fino ai primi
anni del Novecento,è stata inoltre una meta
turistica di rilevanza internazionale per la presenza
di importanti stabilimenti balneari e termali, che
conferirono alla città l'appellativo di Montecatini
al mare. Livorno, che alla fine del XIX secolo contava
circa 100.000 abitanti ed era l'undicesima città
d'Italia e la seconda della Toscana per popolazione,
negli ultimi decenni è andata incontro ad un
sensibile decremento del numero di abitanti, tanto
che oggi risulta essere la terza città della
Toscana dopo Firenze e Prato. Il comune di Livorno
ha una superficie di 104,1 kmq. La città si
trova a 3 metri s.l.m. (quota in piazza del Municipio).
Non vi sono corsi d'acqua rilevanti, a parte alcuni
piccoli torrenti (Rio Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore,
Rio Ardenza). Il terreno è generalmente pianeggiante,
salvo elevarsi a sud, dove inizia il sistema della
Colline livornesi. Conseguentemente anche la costa,
che da Marina di Carrara a Piombino è sempre
bassa, si alza quasi a picco sul mare, nella zona
detta del Romito. Il comune è classificato,
allo stesso modo della maggior parte dei comuni toscani,
con grado di sismicità 9 (categoria 2). Il
territorio comunale di Livorno comprende anche l'isola
di Gorgona e le secche della Meloria facenti parte
del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. L'isola
di Gorgona ha una superficie di 220 ettari e si trova
a 37 chilometri dalla costa labronica.
Livorno
è una città della Toscana, capoluogo
della provincia omonima. Situata lungo la costa del
Mar Ligure, Livorno è uno dei più importanti
porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico,
centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte
le città toscane, è solitamente ritenuta
la più giovane, sebbene nel suo territorio
siano presenti testimonianze storiche di epoche remote
sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda
guerra mondiale. La città, sviluppatasi a partire
dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici,
è celebre per aver dato i natali apersonalità
di prestigio come Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni
e Carlo Azeglio Ciampi. In passato, fino ai primi
anni del Novecento,è stata inoltre una meta
turistica di rilevanza internazionale per la presenza
di importanti stabilimenti balneari e termali, che
conferirono alla città l'appellativo di Montecatini
al mare. Livorno, che alla fine del XIX secolo contava
circa 100.000 abitanti ed era l'undicesima città
d'Italia e la seconda della Toscana per popolazione,
negli ultimi decenni è andata incontro ad un
sensibile decremento del numero di abitanti, tanto
che oggi risulta essere la terza città della
Toscana dopo Firenze e Prato. Il comune di Livorno
ha una superficie di 104,1 kmq. La città si
trova a 3 metri s.l.m. (quota in piazza del Municipio).
Non vi sono corsi d'acqua rilevanti, a parte alcuni
piccoli torrenti (Rio Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore,
Rio Ardenza). Il terreno è generalmente pianeggiante,
salvo elevarsi a sud, dove inizia il sistema della
Colline livornesi. Conseguentemente anche la costa,
che da Marina di Carrara a Piombino è sempre
bassa, si alza quasi a picco sul mare, nella zona
detta del Romito. Il comune è classificato,
allo stesso modo della maggior parte dei comuni toscani,
con grado di sismicità 9 (categoria 2). Il
territorio comunale di Livorno comprende anche l'isola
di Gorgona e le secche della Meloria facenti parte
del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. L'isola
di Gorgona ha una superficie di 220 ettari e si trova
a 37 chilometri dalla costa labronica.
 |
ORIGINI
E CENNI STORICI
Le origini di Livorno sono ignote e si perdono nelle
leggende e nella mitologia. Nel 904 il toponimo "Livorna"
è attestato per la prima volta con riferimento
ad un pugno di case posizionate sulla costa del Mar
Ligure, in una cala naturale, a pochi chilometri a
sud della foce dell'Arno e di Pisa. Il progressivo
interramento del vicino Porto Pisano, il grande sistemaportuale
della Repubblica di Pisa, coincise con l'affermazione
del borgo labronico, che fu dotato, tra il XIII ed
il XIV secolo di un sistema di fortificazioni e di
un maestoso faro, noto col nome di Fanale dei Pisani.
Tramontata
la Repubblica, Livorno fu venduta dapprima ai Visconti
di Milano, e successivamente, nel 1407, ai genovesi,
per passare, nel 1421 ai fiorentini. Nel XVI secolo
i Medici, signori di Toscana, contribuirono in maniera
determinante allo sviluppo di Livorno e del suo sistema
portuale. Bernardo Buontalenti fu pertanto incaricato
di progettare una nuova città fortificata intorno
al nucleo originario dell'abitato labronico, con un
imponente sistema di fossati e bastioni (si veda la
voce Fosso Reale). Il
popolamento della città buontalentiana fu favoritodall'emanazione,
tra il 1590 ed il 1603, delle cosiddette "Leggi
Livornine", che garantivano, per gli abitanti
di Livorno, libertà di culto e di professione
religiosa e politica a chiunque fosse stato ritenuto
colpevole di qualsiasi reato (con alcune eccezioni,
tra le quali l'assassinio e la "falsa moneta").
Invece, dal punto di vista economico, l'istituzione
del porto franco portò ad un proliferare di
attività commerciali spesso legate alle intense
attività portuali. Nel
XVIII secolo, la fine della dinastia medicea e l'avvento
dei Lorena non ostacolarono l'espansione cittadina,
con la formazione di grandi sobborghi suburbani a
ridosso delle fortificazioni buontalentiane. Anche
dal punto di vista culturale il Settecento portò
ad un proliferare delle arti in genere ed in particolaredell'editoria;
qui vennero pubblicati Dei delitti e delle pene di
Cesare Beccaria (nel 1764, in forma anonima) e, nel
1770, la terza edizione dell'Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonnè des Sciences, des Arts
et des Mètieres di Diderot e D'Alembert, in
una stamperia ricavata nel vecchio Bagno dei forzati.
Tra
la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento la
città subì l'assedio delle truppe francesi,
capeggiate da Napoleone Bonaparte, degli Spagnoli
e degli Inglesi. La Restaurazione e il ritorno al
potere dei Lorena con Ferdinando III e poi Leopoldo
II, permise la realizzazione di grandi opere pubbliche,
come il completamento dell'Acquedotto di Colognole,
mentre le fortificazioni medicee furono in gran parte
smantellate per far posto ad eleganti palazzi della
borghesia livornese. Tuttavia
i moti rivoluzionari del 1849 precedettero di pochi
anni la definitiva annessione del Granducato di Toscana
al Regno d'Italia. Con l'unità d'Italia, nel
1868 furono abolite le franchigie doganali di Livorno,
che porteranno ad un drastico calo delle attività
commerciali e dei traffici marittimi, ma lasuccessiva
fondazione del Cantiere navale Orlando farà
cambiar volto alla città trasformandola rapidamente
in un importante centro industriale. Sul finire del
medesimo secolo, il prestigio della città,
ormai prossima ai 100.000 abitanti, fu sancito dall'istituzione
della celebre Accademia Navale.
 |
Gli
inizi del XX secolo portarono ad un fiorire di numerosi
progetti architettonci ed urbanistici: dagli eleganti
stabilimentitermali e balneari, che avevano fatto
di Livorno una delle mete turistiche più ambite
sin dalla prima metà dell'Ottocento, alla nuova
stazione ferroviaria della linea Livorno - Cecina
sino ai piani di risanamento del centro. Poco prima
dell'avvento del Fascismo, Livorno fu teatro della
fondazione del Partito Comunista Italiano, a seguito
della scissione della corrente di estrema sinistra
dal Partito Socialista Italiano. L'affermazione
del fascismo e l'ascesa politica di Costanzo Ciano
portarono alla realizzazione di grandi opere pubbliche
ed industriali, all'ampliamento dei confini provinciali
e, al contempo, all'ideazione di massicci e scellerati
piani di sventramento per la città, che mutarono
parte dell'antico assetto urbanistico. Lo
scoppio della seconda guerra mondiale e i successivi
bombardamenti causarono la distruzione di gran parte
della città storica e la morte di numerosi
civili: ingenti danni si registrarono anche nelle
aree industriali e portuali, che furono tra i principali
obbiettivi delle incursioni aeree. La ricostruzione
postbellica durò molti anni: lo sminamento
di alcune zone del centro cittadino terminò
solo negli anni cinquanta, mentre la cinquecentesca
Fortezza Nuova ospitò baracche di sfollati
fino agli anni sessanta.
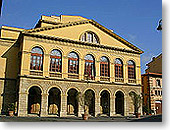 |
Livorno
acquistò il volto di una città moderna
e fortemente industrializzata, ma la crisi avviata
dal disimpegno dellapartecipazione pubblica nei grandi
centri industriali ha portato negli ultimi anni ad
uno spostamento del baricentro economico dall'industria
pesante alle piccole e medie imprese e al terziario.
Dopo
le distruzioni subite nel corso della seconda guerra
mondiale e le successive mutilazioni inflitte alla
città con laricostruzione, Livorno ha perso
gran parte del suo retaggio storico, anche se resistono
vestigia delle sue varie fasi: in particolare la struttura
del centro cittadino, un pentagono fortificato costruito
secondo i criteri della città ideale del Cinquecento.
Numerose poi sono le chiese, i templi ed i cimiteri
di diverse confessioni religiose, simbolo di un perfetto
connubio di razze e popolazioni diverse, che hanno
influito notevolmente nella cultura cittadina. Questo
spirito di reciproca tolleranza, unito in passato
alla politica illuminata dei granduchi di Toscana,
creò infatti un'intensa attività culturale.
Importanti librerie e prestigiosi teatri animavano
la vita della città: qui ad esempio fu pubblicata
l'edizione italiana dell'Encyclopédie, mentre
numerosi letterati, come Tobias Smollet o Carlo Goldoni,
soggiornarono nelle amene località intorno
a Livorno. Grandi opere d'architettura di pubblica
utilità sorsero poi nella prima metà
dell'Ottocento, quando la città iniziò
ad affermare una vocazione turistica che porterà
all'apertura di molti stabilimenti balneari in cui
ancor oggi si avvertono gli echi di una lontana Belle
époque.
 |
Duomo
Dedicato a San Francesco, fu iniziato alla fine del
Cinquecento su progetto di Alessandro Pieroni. Successivamente
fu ampliato con l'aggiunta di due cappelle laterali.
Da segnalare il pregevole soffitto ligneo intagliato,
andato perduto nel corso dell'ultima guerra mondiale,
a seguito della quasi totale distruzione della chiesa.
Chiesa di San Ferdinando
Iniziata nel 1707 su progetto di Giovan Battista Foggini,
fu conclusa nel 1716; in stile barocco, con una facciata
incompleta, presenta una pianta a croce latina. Notevole
il gruppo scultoreo conservato presso l'altare e opera
di Giovanni Baratta, che rappresenta la liberazione
degli schiavi. La chiesa era affidata all'ordine dei
Trinitari.
Chiesa di Santa Caterina
Iniziata nel 1720 su progetto di Giovanni del Fantasia,
fu consacrata nel 1755. A pianta ottagonale, la chiesa
è caratterizzata da una grande cupola, alta
63 metri e ridotta all'aspetto di torrione a causa
di problemi di natura statica. All'interno si può
ammirare un notevole dipinto ad olio del Vasari.
Chiesa di Santa Maria del Soccorso
Fu costruita su progetto di Gaetano Gherardi a seguito
della violenta epidemia di colera che nel 1835 causò
oltre millemorti in città. Si tratta della
più grande chiesa di Livorno (90 metri di lunghezza):
la facciata è caratterizzata da tre finestre
semicircolari, mentre l'interno, a croce latina, è
suddiviso in tre navate, con una piccola cupola al
transetto.
Santuario di Montenero
Il colle di Montenero, fin dalla prima metà
del XIV secolo è meta di pellegrinaggi. L'attuale
santuario risale al XVIII secolo ed al suo interno
sono custoditi un numero rilevante di ex-voto. Sulla
piazza antistante, sotto un loggiato, sono situate
alcune tombe di livornesi illustri, come Francesco
Domenico Guerrazzi e Giovanni Fattori.
Chiesa armena di San Gregorio Illuminatore
Fu costruita nei primi anni del Settecento. Danneggiata
durante la seconda guerra mondiale, fu abbattuta durante
la ricostruzione del centro cittadino. Oggi resta
solo la facciata, mentre alcuni resti delle decorazioni
interne sono abbandonati nel giardino pubblico di
Villa Fabbricotti.
Chiesa di San Giorgio già anglicana
Sorta come chiesa anglicana, fu progettata da Angiolo
della Valle e consacrata nel 1844. Di gusto neoclassico,
presenta una facciata ornata da un portico sormontato
da un frontone. Nel dopoguerra è stata restaurata
e consacrata al culto cattolico.
Chiesa dei Greci Uniti
Fu costruita nei primi anni del Seicento e intitolata
alla Santissima Annunziata. È stata la chiesa
nazionale dei greci che prestavano il loro servizio
sulle navi dell'Ordine di Santo Stefano. Semidistrutta
durante la seconda guerra mondiale, è sopravvissuta
pressoché intatta la facciata settecentesca.
L'interno, ricostruito, ospita una preziosa iconostasi.
Chiesa greco-ortodossa della Santissima Trinità
Non più esistente, era stata inaugurata nel
1760 come la prima chiesa acattolica della Toscana.
Fu demolita durante la costruzione del Palazzo del
Governo, mentre i suoi arredi oggi si trovano nella
cappella del Cimitero greco-ortodosso divia Mastacchi.
Chiesa valdese
In stile neogotico, fu costruita intorno alla metà
dell'Ottocento e fu sede, fino ai primi anni del Novecento,
della chiesa Presbiteriana Scozzese. Al fine di non
turbare il clero cattolico, fu imposto al progettista
di realizzare un edificio simile ad un palazzo, comprendente
anche gli alloggi pastorali.
Sinagoga ebraica
L'antica sinagoga seicentesca, una della più
grandi d'Europa, fu gravemente danneggiata nel corso
dell'ultima guerra mondiale. Per volontà della
comunità ebraica fu deciso di abbattere gli
antichi resti e di costruire una nuova sinagoga, inaugurata
nel 1962 e che nelle sue forme architettoniche richiama
la Grande Tenda nella quale veniva custodita l'Arca
dell'Alleanza.
Tempio della Congregazione Olandese Alemanna
Questa chiesa protestante, fu costruita in stile neogotico
tra il 1862 e il 1864 su progetto dell'architetto
Dario Giacomelli. La facciata è ornata da tre
rosoni e finestre bifore, mentre l'interno presenta
un'aula a pianta rettangolare aperta da finestre ogivali
e una tribuna posta sopra il vestibolo d'ingresso.
La chiesa è da anni in stato di completo abbandono.
TERME
Bagnetti della Puzzolente
Si trovano nell'omonima località dove è
presente una polla d'acqua solfurea. Lo stabilimento
termale fu progettato da Pasquale Poccianti e completato
nel 1844; l'impresa tuttavia non ebbe gli esiti sperati
e i Bagnetti furono chiusi e destinati ad altri usi.
Oggi necessitano di urgenti restauri.
Stabilimento termale Acque della Salute
Questo stabilimento è una pregevolissima architettura
d'inizio Novecento che si inserisce a breve distanza
dalla Stazione Centrale. Svolse la sua attività
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, mentre
nel 1968 fu danneggiato da un incendio: oggi versa
in pessime condizioni di conservazione.
 |
MUSEI
G. Fattori, Campagna romana, Museo Civico "G.
Fattori"
Museo Civico "Giovanni Fattori"
Allestito intorno alla metà degli anni novanta
del Novecento nella suggestiva cornice di Villa Mimbelli
(via San Jacopo in Acquaviva), ospita un'importante
raccolta di opere dei Macchiaioli e dei Postmacchiaioli,
movimenti che si svilupparono a Livorno ed in altre
località della costa labronica.
Museo ebraico "Yeshivà Marini"
Situato in (via Micali 21), oltre ad una collezione
di arredi e paramenti sacri del culto ebraico (in
gran parte portati qui dalla vecchia Sinagoga che
fu distrutta a seguito dei bombardamenti della seconda
guerra mondiale), si possono qui trovare raccolte
di libri dal XVII al XX secolo ed un Hekhàl
del Cinquecento che contiene i rotoli della Torah.
Museo Mascagnano
Raccoglie i cimeli appartenuti al musicista livornese
Pietro Mascagni. Il percorso museale è stato
recentemente allestito presso il Teatro Goldoni.
Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo
(sito ufficiale)
Ubicato in via Roma, fu fondato nel 1929. Si tratta
di un museo ritenuto all'avanguardia sia dal punto
di vista del contenuto esposto, che delle strutture.
Museo di Santa Giulia
È situato presso l'omonima chiesa, in (Largo
Duomo). Contiene arredi sacri, paramenti liturgici
e l'antica tavola di scuola giottesca raffigurante
Santa Giulia con scene della sua vita e del martirio.
Galleria degli ex voto
La galleria occupa un'ala del Santuario di Montenero,
in piazza di Montenero 9. Espone una tra le più
grandi raccolte di ex voto d'Italia, donati dai primi
anni dell'Ottocento sino ad oggi.
VERNACOLO
Il vernacolo livornese è fondamentalmente una
variante del toscano nord-occidentale (parlato anche
nelle province di Pisa e Lucca), ma se ne discosta
per certi tratti tipici della pronuncia, i più
appariscenti dei quali sono alcune vocali molto aperte
e la /k/ singola intervocalica che viene completamente
elisa (e non soltanto aspirata, come accade nella
maggior parte delle parlate toscane), mentre quella
doppia rimane tale. Per esempio la frase "la
mia casa" diviene la mi' 'asa, mentre invece
la frase "vado a casa" rimane tale perché
nella pronuncia italiana la "c" è
raddoppiata (vado a ccasa); anche in una frase come
"Il cane abbaia" la "c" rimane
integra perché non è intervocalica.
Del
tutto peculiare è anche la frequente interiezione
"dé", da non confondere col "deh"
esortativo italiano, ormai desueto. Al contrario,
il "dé" livornese è praticamente
onnipresente, e può assumere un vasto spettro
di significati, spesso decodificabili solo mediante
l'intonazione. Assieme al "dé" spesso
troviamo il termine "boia", che viene usato
come esclamazione ("Boiadé").
Inoltre,
il lessico contiene tracce (vocaboli e locuzioni)
di alcune delle numerose lingue parlate dalle comunità
ospitate da Livorno attraverso i secoli: ad esempio
talvolta i piedi vengono detti "le fétte"
parafrasando alla buona il vocabolo inglese "feet",
tale iterpretazione deriva dal periodo della seconda
guerra mondiale, in quanto i soldati americani presenti
a Livorno utilizzavano l'inglese per parlare con i
livornesi, conoscendo solo poche parole di italiano.
Ad esempio, per dire "Hai i piedi grandi"
si può sentir dire "Ciai dù fètte
paiono zattere". E a tal proposito, la grafia
livornese corretta "ci hai" e "ci hanno"
sarà sempre "ciai" (pron. ciài)
e "cianno" (pron. ciànno), mai l'orribile
"c'hai", che equivale foneticamente a "kai"...Va
anche notata la presenza, in seno alla numerosa presenza
ebraica, del bagitto, ormai però relegato ai
pochi che ne conservano ricordo.
Altra
particolarità, stavolta retorica, è
l'uso di una forma di ironia che consiste nell'uso
di locuzioni iperboliche con una determinata intonazione,
per significare l'esatto opposto: ad esempio, "e
sei parigino!", per intendere che l'interlocutore
è tutt'altro che proveniente da Parigi (città
dell'eleganza e del buon gusto per antonomasia).
Grande
rappresentanza del vernacolo livornese viene data
anche dal Vernacoliere, mensile di satira politica/sociale
diretto da Mario Cardinali, che include varie rubriche
di attualità, vignette, fumetti, posta dei
lettori tutte (o quasi) rigorosamente in vernacolo
livornese. Il mensile non solo è apprezzato
e diffuso a livello locale, ma è seguito da
appassionati del genere in tutta Italia.
IL
PORTO
Il porto di Livorno è, sin dalle sue origini,
uno dei più importanti del Mediterraneo: può
movimentare qualsiasi tipo di merce, da quella liquida
a quella solida in rinfusa, alle automobili,ai prodotti
congelati, alla frutta, agli impianti destinati alle
imprese industriali, ma soprattutto movimenta migliaia
di containers in arrivo ed in partenza per tutto il
mondo.
Inoltre
il porto labronico è anche un frequentato scalo
passeggeri, capace di ospitare anche i più
grandi transatlantici del mondo, come il "Queen
Mary 2", che ha fatto di Livorno una rotta abituale.
Al consueto traffico passeggeri, interessato ai traghetti,
si è aggiunto, negli ultimi anni, quello crocieristico,
con circa 350 navi l'anno e più di 250.000
croceristi in transito; si calcola che in totale il
porto abbia circa due milioni di utenti annui.
La
città dispone anche di porticcioli per imbarcazioni
da diporto: oltre al porto "Nazario Sauro",
situato nei pressi dello scalo maggiore, altri approdi
si trovano nei quartieri di Ardenza, Antignano e nella
frazione di Quercianella. I fossi medicei ospitano pure
un gran numero di imbarcazioni di modeste dimensioni.