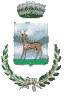 Codigoro
è un comune della provincia di Ferrara. Il
comune di Codigoro si trova su di un territorio totalmente
pianeggiante nel Parco regionale del Delta del Po,
immerso nella Pianura Padana e a poca distanza dalle
Valli di Comacchio e dalle coste del Mare Adriatico
ed è attraversato per un breve tratto dal Po
di Volano. Il territorio circostante l'abitato urbano
è caratterizzato dalla presenza di campi coltivati
e da numerosi canali di irrigazione, risultato delle
bonifiche avvenute nella zona del basso ferrarese
che videro il ritiro delle acque del Po e la sua conseguente
deviazione verso il Veneto. Confina con i comuni di
Massa Fiscaglia, Lagosanto, Comacchio, Jolanda di
Savoia e Goro.
Codigoro
è un comune della provincia di Ferrara. Il
comune di Codigoro si trova su di un territorio totalmente
pianeggiante nel Parco regionale del Delta del Po,
immerso nella Pianura Padana e a poca distanza dalle
Valli di Comacchio e dalle coste del Mare Adriatico
ed è attraversato per un breve tratto dal Po
di Volano. Il territorio circostante l'abitato urbano
è caratterizzato dalla presenza di campi coltivati
e da numerosi canali di irrigazione, risultato delle
bonifiche avvenute nella zona del basso ferrarese
che videro il ritiro delle acque del Po e la sua conseguente
deviazione verso il Veneto. Confina con i comuni di
Massa Fiscaglia, Lagosanto, Comacchio, Jolanda di
Savoia e Goro.
ETIMOLOGIA
Documentato con il nome di caput Gauri era un composto
di caput (capo, inizio) e Goro (nome di un canale
del Po) che assunse, con il tempo, il significato
di fossato, canale.
DA
VEDERE
Abbazia di Pomposa: rappresenta uno dei monumenti
religiosi più importanti del Nord Italia, eretta
nel IX secolo e dimora dei Benedettini;
Palazzo del Vescovo: costruito per volere dei Benedettini,
l'edificio rappresentava la sede amministrativa di
Codigoro e Pomposa. Anticamente denominato Domus Dominicata
il palazzo fu oggetto di restauro in stile veneziano
nel 1732 e ceduto al vescovo di Comacchio da cui oggi
ne deriva il nome. Oggi ospita la biblioteca comunale
ed è sede di manifestazioni culturali;
Torre della Finanza: fu realizzata durante i primi
anni del 700 di controllare le rotte commerciali sulle
sponde del Po di Volano. Fu fatta erigere dal Governo
Pontificio ma, a causa della continua erosione della
costa su cui si ergeva, la costruzione venne completamente
distrutta durante una mareggiata nel 1729. Fu ricostruita
a cominciare dal 1739 ed ultimata nel 1741 per essere
adibita a caserma della Guardia di Finanza fino ai
primi anni del 900.
ABBAZIA
DI POMPOSA
L'Abbazia di Pomposa situata nel comune di Codigoro
in provincia di Ferrara è un'abbazia risalente
al IX secolo e una delle più importanti di
tutto il Nord Italia. Si hanno notizie di un'abbazia
benedettina a partire dal IX secolo ma probabilmente
l'insediamento era anteriore di due o tre secoli.
L'abbazia che noi oggi ammiriamo venne consacrata
nel 1026 (quindi edificata prima) dall'abate Guido.
Alla basilica il magister Mazulo aggiunse un nartece
con tre grandi arcate. Fino al XIV secolo, l'abbazia
godette di proprietà sparse in tutta Italia
grazie alle donazioni, poi ebbe un lento declino dovuto
a fattori geografici e ambientali quali la malaria
e l'impaludamento della zona. Ebbe una grande importanza
per la conservazione e la diffusione della cultura
durante il Medioevo grazie ai monaci amanuensi che
vi risiedevano. In quest'abbazia, il monaco Guido
d'Arezzo inventò le note musicali moderne.
Dalla fine dell'Ottocento appartiene allo Stato Italiano.
Santa
Maria
La basilica di tipo ravennate risale al periodo VII-IX
secolo; venne successivamente allungata e venne aggiunto
l'atrio ornato di fregi in cotto, oculi e scodelle
maiolicate. All'interno della chiesa a tre navate,
sulle pareti affreschi trecenteschi di scuola bolognese
e nell'abside affreschi di Vitale da Bologna.
Campanile
Altissimo rispetto al resto dell'edificato (48 metri),
il campanile è del 1063 in forme lombarde e
ricorda quello, di circa 75 metri, dell'Abbazia di
San Mercuriale nella non lontana Forlì. Grazie
ad una lastra iscritta conosciamo il nome dell'architetto
che progettò il campanile e ne diresse i lavori
di costruzione: Deusdedit. Procedendo dalla base verso
la sommità del campanile le finestre aumentano
di numero e diventano più ampie seguendo una
tendenza classica di quel periodo, che serviva ad
alleggerire il peso della torre e a propagare meglio
il suono delle campane.
Monastero
Restano la sala capitolare ornata di affreschi degli
inizi del Trecento di un diretto scolaro di Giotto;
il refettorio che ha sulla parete di fondo il più
prezioso ciclo di affreschi dell'abbazia attribuito
a un maestro riminese forse il Maestro della Cappella
di San Nicola. Notevole anche il palazzo della Ragione.
ORIGINI
E STORIA
La storia di Codigoro la si fa ricondurre al IX secolo
quando una comunità di Benedettini si insedia
nel territorio dell'attuale Pomposa che allora era
posizionato su un isolotto bagnato dal Mare Adriatico
e dai rami del Po di Volano e del Po di Goro. È
in questi anni che prende avvio la costruzione dell'Abbazia
di Pomposa la quale diede risalto a Codigoro e al
suo territorio il quale acquisì maggiore rilevanza
grazie ai redditizi terreni agricoli e all'istituzione
del Palazzo del Vescovo il quale concentrava su di
se il governo politico e commerciale fino all'assorbimento
di Codigoro da parte dell'Esarcato di Ravenna al quale
prenderà parte sino all'anno 1000. Verso il
1150 hanno inizio le pressioni per il controllo sul
territorio da parte degli Este, signori di Ferrara,
ma sono anche gli anni che vedono la fine della prosperità
di Codigoro a causa della Rotta di Ficarolo, avvenuta
nel 1152, a causa della quale il corso fluviale del
Po si spostò a nord prosciugando le acque del
Volano fino all'abbandono dell'Abbazia di Pomposa
e di Codigoro dai frati Benedettini. Hanno inizio
quindi le opere di bonifica del territorio, iniziate
nel 1464 e terminate nel 1580, promosse dai duca d'Este
e che riuscirono, anche se in piccola parte, a rendere
più vivibile il territorio codigorese. Successivamente
infatti la Repubblica di Venezia attuò una
modifica al flusso del Po di Levante facendolo sboccare
più a sud in territorio ferrarese rendendo
così vane le opere idrauliche portate a compimento
dagli Este. Le opere di bonifica riprendono nel 1598
quando Ferrara passò sotto il dominio dello
Stato della Chiesa sino alla metà dell'800
quando vennero costruiti i primi impianti idrovori
e venne attuata la bonifica del circondario Polesine
di Ferrara.