
 Capoluogo
della provincia omonima e della regione Campania,
è il terzo comune d'Italia per numero di abitanti
con una popolazione di quasi un milione di abitanti,
pari a oltre un sesto dell'intera popolazione regionale
e circa un terzo di quella della sua provincia. Napoli
gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni
miti e piovosi e estati calde e secche, ma comunque
rinfrescate dalla brezza marina che raramente manca
sul suo golfo. Il sole splende mediamente per 250
giorni l'anno. La classificazione climatica di Napoli
inserisce la città nella zona climatica "C".
La particolare conformazione morfologica del territorio
del capoluogo comunque obbliga in questa sede ad aggiungere
che la città possiede al suo interno differenti
microclimi con la possibilità così di
incontrare variazioni climatiche anche significative
spostandosi di pochi chilometri.Non mancano però
episodi di gelo: restano infatti celebri le nevicate
su Napoli del Febbraio 1956, del Gennaio 1985 e del
26 gennaio e 1 marzo del 2005, dove vi furono accumuli
fino a 10 cm anche lungo la costa. La città
vera e propria si estende tuttavia ben oltre la superficie
comunale, sebbene non possa essere univoca una definizione
dei suoi confini. Dati ONU del 2005 assegnano all'intero
agglomerato urbano napoletano una popolazione di circa
2.200.000 abitanti, ma va ricordato che vi sono dati
di diverse fonti che appaiono anche estremamente discordanti
a seconda del metodo di calcolo utilizzato (non solo
per l'agglomerato urbano ma anche soprattutto per
la definizione dei confini dell'area metropolitana).
Capoluogo
della provincia omonima e della regione Campania,
è il terzo comune d'Italia per numero di abitanti
con una popolazione di quasi un milione di abitanti,
pari a oltre un sesto dell'intera popolazione regionale
e circa un terzo di quella della sua provincia. Napoli
gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni
miti e piovosi e estati calde e secche, ma comunque
rinfrescate dalla brezza marina che raramente manca
sul suo golfo. Il sole splende mediamente per 250
giorni l'anno. La classificazione climatica di Napoli
inserisce la città nella zona climatica "C".
La particolare conformazione morfologica del territorio
del capoluogo comunque obbliga in questa sede ad aggiungere
che la città possiede al suo interno differenti
microclimi con la possibilità così di
incontrare variazioni climatiche anche significative
spostandosi di pochi chilometri.Non mancano però
episodi di gelo: restano infatti celebri le nevicate
su Napoli del Febbraio 1956, del Gennaio 1985 e del
26 gennaio e 1 marzo del 2005, dove vi furono accumuli
fino a 10 cm anche lungo la costa. La città
vera e propria si estende tuttavia ben oltre la superficie
comunale, sebbene non possa essere univoca una definizione
dei suoi confini. Dati ONU del 2005 assegnano all'intero
agglomerato urbano napoletano una popolazione di circa
2.200.000 abitanti, ma va ricordato che vi sono dati
di diverse fonti che appaiono anche estremamente discordanti
a seconda del metodo di calcolo utilizzato (non solo
per l'agglomerato urbano ma anche soprattutto per
la definizione dei confini dell'area metropolitana).
 L'area
metropolitana secondo le stime dell'OCSE giungerebbe
a circa 3.100.000 abitanti, dietro Milano e Roma.
Da altre fonti risulta essere la seconda area metropolitana
d'Italia per popolazione dopo Milano, solo per citarne
alcune: per l' U.S. Census Bureau and Times Atlas
of the World ne stima una popolazione di circa 3 milioni
di abitanti, mentre il World Gazetteer ne calcola
3.832.622. L'area
metropolitanarisulta, ad ogni modo, una delle più
popolose e densamente popolate dell'Unione Europea:
è prossima inoltre l'istituzione della città
metropolitana che dovrebbe andare a sostituire la
Provincia di Napoli. Gli urbanisti chiamano l'intero
territorio urbanizzato "la grande Napoli";
la crescita della città è riuscita infatti
ad integrare a sé comuni della provincia di
Salerno e Caserta quasi senza soluzione di continuità.
La costa metropolitana si estende ininterrottamente
da Capo Miseno a Castellammare di Stabia. Il
comune è composto dalla "città
storica" (corrispondente ai quartieri di Avvocata,
Chiaia, Mercato, Montecalvario, Pendino, Porto, Posillipo,
San Carlo all'Arena, San Giuseppe, San Lorenzo, Stella,
Vicaria), da alcune frazioni fuse con la città
in varie fasi già dall'epoca di Gioacchino
Murat (Arenella, Bagnoli, Miano, Piscinola, Fuorigrotta,
Vomero) e dai comuni aggregati infine durante il ventennio
fascista (attualmente suddivisi nei quartieri di Barra,
Chiaiano, Pianura, Soccavo, Ponticelli, San Giovanni
a Teduccio, San Pietro a Patierno, Secondigliano e
Scampìa). I
quartieri più popolosi sono appunto quelli
corrispondenti al territorio dei comuni aggregati
durante il ventennio. La sovrappopolazione di tali
zone, che hanno da sole i due terzi della popolazione
della città, è dovuta principalmente
alla scelta politica - poi rivelatasi fallimentare
- di individuare in quei luoghi le aree in cui realizzare
gli agglomerati ex legge167/1962 (edilizia residenziale
pubblica) e legge 219/1981 (edilizia residenziale
pubblica per i terremotati del 1980).
L'area
metropolitana secondo le stime dell'OCSE giungerebbe
a circa 3.100.000 abitanti, dietro Milano e Roma.
Da altre fonti risulta essere la seconda area metropolitana
d'Italia per popolazione dopo Milano, solo per citarne
alcune: per l' U.S. Census Bureau and Times Atlas
of the World ne stima una popolazione di circa 3 milioni
di abitanti, mentre il World Gazetteer ne calcola
3.832.622. L'area
metropolitanarisulta, ad ogni modo, una delle più
popolose e densamente popolate dell'Unione Europea:
è prossima inoltre l'istituzione della città
metropolitana che dovrebbe andare a sostituire la
Provincia di Napoli. Gli urbanisti chiamano l'intero
territorio urbanizzato "la grande Napoli";
la crescita della città è riuscita infatti
ad integrare a sé comuni della provincia di
Salerno e Caserta quasi senza soluzione di continuità.
La costa metropolitana si estende ininterrottamente
da Capo Miseno a Castellammare di Stabia. Il
comune è composto dalla "città
storica" (corrispondente ai quartieri di Avvocata,
Chiaia, Mercato, Montecalvario, Pendino, Porto, Posillipo,
San Carlo all'Arena, San Giuseppe, San Lorenzo, Stella,
Vicaria), da alcune frazioni fuse con la città
in varie fasi già dall'epoca di Gioacchino
Murat (Arenella, Bagnoli, Miano, Piscinola, Fuorigrotta,
Vomero) e dai comuni aggregati infine durante il ventennio
fascista (attualmente suddivisi nei quartieri di Barra,
Chiaiano, Pianura, Soccavo, Ponticelli, San Giovanni
a Teduccio, San Pietro a Patierno, Secondigliano e
Scampìa). I
quartieri più popolosi sono appunto quelli
corrispondenti al territorio dei comuni aggregati
durante il ventennio. La sovrappopolazione di tali
zone, che hanno da sole i due terzi della popolazione
della città, è dovuta principalmente
alla scelta politica - poi rivelatasi fallimentare
- di individuare in quei luoghi le aree in cui realizzare
gli agglomerati ex legge167/1962 (edilizia residenziale
pubblica) e legge 219/1981 (edilizia residenziale
pubblica per i terremotati del 1980).
ORIGINE
E CENNI STORICI
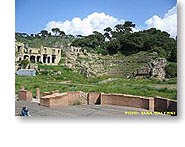 Alcune tombe risalenti all'epoca eneolitica (fine
III millennio a.C.) rinvenute nel quartiere di Materdei,
da attribure allaantichissima Cultura del Gaudo provano
che l'area cittadina fu abitata già prima dell'arrivo
dei coloni greci. La città fu probabilmente
fondata dagli abitanti della colonia greca di Cuma
attorno all'VIII secolo a.C., con il nome di Partenope,
sull'attuale Monte Echia. Tale insediamento sarebbe
stato successivamente chiamato Palepolis ("città
vecchia"), quando la città sarebbe stata
rifondata poco lontano nel V secolo a.C., con il nuovo
nome di Néa-pólis, ("città
nuova"). Nel 326 a.C., a seguito delle guerre
sannitiche, i Romani conquistarono definitivamente
la città, che conservò però la
lingua greca almeno fino al II secolo d.C. Nei secoli
seguenti Napoli ospitò molti patrizi ed imperatori
romani che trascorsero qui pause di governo. In particolare,
nel 476 d.C. l'ultimo imperatore romano d'occidente
RomoloAugusto fu imprigionato nel Castel dell'Ovo.
Nel 536 Napoli fu conquistata dai Bizantini durante
la guerra gotica e rimase saldamente in mano all'Impero
anche durante la susseguente invasionelongobarda,
divenendo in seguito ducato autonomo. La vita del
ducato fu caratterizzata da continue guerre, principalmente
difensive, contro i potenti principati longobardi
vicini ed i Saraceni. Attorno al 990, pochi anni dopo
l'istituzione dell'arcidiocesi di Capua, Sergio fu
il primo arcivescovo della città, quando la
sua diocesi fu elevata a provincia ecclesiastica dal
Papa, poco dopo che Leone III l'Isaurico, a seguito
delle dispute teologiche sorte attorno al movimento
iconoclasta, passò le diocesi dell'Italia bizantina
sotto l'autorità del patriarcato di Costantinopoli.
Nel 1137 i normanni diRuggero II conquistarono la
città, ponendo fine al ducato, e Napoli entrò
così a far parte del territorio del Principato
di Capua, nel neonato Regno di Sicilia, con capitale
Palermo; ciononostante la città conservò
la sede dell'arcidiocesi. Dopo la dominazione sveva,
durante la quale fu compresa nel giustizierato di
Terra di Lavoro, nel 1266 gli Angioini occuparono
il Mezzogiorno e, non avendo conquistato la Sicilia,
insediarono la capitale a Napoli durante il regno
di Carlo II, trasformando da allora quella che era
stata una delle tante città marinare del Tirreno
(Amalfi, Gaeta, Sorrento) in uno dei più importanti
centri di potere della penisola italiana. L'ultima
grande impresa degli angioini napoletani fu la spedizione
militare di Ladislao I di Napoli, il primo tentativo
di riunificazione politica d'Italia, agli inizi del
XV secolo.
Alcune tombe risalenti all'epoca eneolitica (fine
III millennio a.C.) rinvenute nel quartiere di Materdei,
da attribure allaantichissima Cultura del Gaudo provano
che l'area cittadina fu abitata già prima dell'arrivo
dei coloni greci. La città fu probabilmente
fondata dagli abitanti della colonia greca di Cuma
attorno all'VIII secolo a.C., con il nome di Partenope,
sull'attuale Monte Echia. Tale insediamento sarebbe
stato successivamente chiamato Palepolis ("città
vecchia"), quando la città sarebbe stata
rifondata poco lontano nel V secolo a.C., con il nuovo
nome di Néa-pólis, ("città
nuova"). Nel 326 a.C., a seguito delle guerre
sannitiche, i Romani conquistarono definitivamente
la città, che conservò però la
lingua greca almeno fino al II secolo d.C. Nei secoli
seguenti Napoli ospitò molti patrizi ed imperatori
romani che trascorsero qui pause di governo. In particolare,
nel 476 d.C. l'ultimo imperatore romano d'occidente
RomoloAugusto fu imprigionato nel Castel dell'Ovo.
Nel 536 Napoli fu conquistata dai Bizantini durante
la guerra gotica e rimase saldamente in mano all'Impero
anche durante la susseguente invasionelongobarda,
divenendo in seguito ducato autonomo. La vita del
ducato fu caratterizzata da continue guerre, principalmente
difensive, contro i potenti principati longobardi
vicini ed i Saraceni. Attorno al 990, pochi anni dopo
l'istituzione dell'arcidiocesi di Capua, Sergio fu
il primo arcivescovo della città, quando la
sua diocesi fu elevata a provincia ecclesiastica dal
Papa, poco dopo che Leone III l'Isaurico, a seguito
delle dispute teologiche sorte attorno al movimento
iconoclasta, passò le diocesi dell'Italia bizantina
sotto l'autorità del patriarcato di Costantinopoli.
Nel 1137 i normanni diRuggero II conquistarono la
città, ponendo fine al ducato, e Napoli entrò
così a far parte del territorio del Principato
di Capua, nel neonato Regno di Sicilia, con capitale
Palermo; ciononostante la città conservò
la sede dell'arcidiocesi. Dopo la dominazione sveva,
durante la quale fu compresa nel giustizierato di
Terra di Lavoro, nel 1266 gli Angioini occuparono
il Mezzogiorno e, non avendo conquistato la Sicilia,
insediarono la capitale a Napoli durante il regno
di Carlo II, trasformando da allora quella che era
stata una delle tante città marinare del Tirreno
(Amalfi, Gaeta, Sorrento) in uno dei più importanti
centri di potere della penisola italiana. L'ultima
grande impresa degli angioini napoletani fu la spedizione
militare di Ladislao I di Napoli, il primo tentativo
di riunificazione politica d'Italia, agli inizi del
XV secolo.
 TURISMO
TURISMO
Il turismo, nonostante la vastità dell'offerta
monumentale e museale di cui la città dispone
non trova sufficiente valorizzazione economica: i
problemi d'immagine della città di Napoli legati
al problema della criminalità organizzata,
nonché l'insufficienza di strutture ricettive
di medio-basso livello sono il principale ostacolo
al decollo di un'efficiente promozione alberghiera.
Il flusso turistico è essenzialmente di passaggio,
diretto verso località periferiche Pompei (in
cui si registra una media di 3 milioni di turisti
l'anno[29]), o le isole del golfo (Capri e Ischia),
la costiera sorrentina e quella amalfitana, dove la
qualità ambientale e l'offerta ricettiva raggiunge
livelli di prestigiointernazionale. Negli ultimi anni
si è riscontrata nel porto di Napoli una notevole
crescita nel settore croceristico.
Di
discreto interesse turistico è anche la tradizione
artigianale napoletana, specializzata e promossa in
apposite mostre, nell'arte presepiale e nella lavorazionedi
ceramiche e porcellane; infine, un importante settore
industriale cittadino è occupato dalle produzioni
tessile e dell'abbigliamento.
Napoli
è una delle città mondiali a maggior
densità di risorse culturali e monumenti che
ne testimoniano la sua evoluzione storico-artistica;
il centro storico,annoverato dall'Unesco tra i patrimoni
dell'umanità, è il risultato di sovrapposizioni
di stili architettonici, a racchiudere circa 2.800
anni di storia e a testimonianza delle varie civiltà
che vi hanno soggiornato; su un territorio relativamente
poco esteso sono presenti, tra gli altri, un grande
numerodi castelli, residenze reali, palazzi monumentali,
chiese storiche e resti dell'età classica.
L'eredità di questa storia millenaria si può
comunque ammirare anche in tutta la città e
nei suoidintorni.
Tuttavia,
la scarsa valorizzazione e la mancanza di fondi per
eventuali restauri, fa sì che parte di tale
patrimonio versi a volte in rovina o in stato di degrado
(sono più di 160 le chiese che rischiano di
"scomparire", altrettanti i palazzi; ma
anche fontane, obelischi, architetture antiche ed
altri beni culturali di valore). Per far fronte a
questa emergenza, varie organizzazioni e comitati
cittadini, stanno cercando di far intervenire l'Unesco.
 CASTELLI
CASTELLI
La Napoli antica che aveva a lungo goduto di un'eccellente
protezione da parte della capitale dell'Impero romano
(anchegrazie alla vicinanza con quest'ultima), al
passaggio dall'età classica al medioevo, dovette
presto ritornare a difendersi da sola. Città
di mare e senza difese naturali nell'entroterra, (ma
anche destinata ad assumere un ruolo di rilievo),
fu protagonista di numerosi assedi che dovette subire
soprattutto nel periodo del Ducato autonomo; in questo
periodo la città si ritrovò in una continua
e quasi ininterrotta sequenza di guerre, prevalentemente
difensive, contro i principati longobardi di Benevento,
di Salerno e di Capua, gli imperatori bizantini, i
pontefici ed infine i Normanni che la riuscirono ad
espugnare definitivamente nel 1137.
I
castelli difensivi giunti sino a noi intatti nella
struttura sono sei, cinque nel centro storico (Maschio
Angioino o Castel Nuovo, Castel Capuano, CastelSant'Elmo,
Castel dell'Ovo e la Caserma Garibaldi, costruita
appunto a mò di castello fortificato), e l'altro
in zona periferica, il Castello di Nisida di epoca
tardo-angioina che oggi ospita la Colonia di Redenzione
per Minorenni. Vanno inoltre menzionati i resti di
altri due castelli: il Forte di Vigliena e il Castello
del Carmine. Altre stutture della città hanno
forme ed aspetto di castelli (Castello Aselmeyer),
il cui interesse storico è limitato al significato
artistico e decorativo della struttura.
CASTEL
NUOVO
I primi castelli di Napoli ebbero per lo più
la funzione di residenze reali: Carlo I d'Angiò
decise di erigere il Castel Nuovo principalmente come
sua residenza. La dinastia Aragonese rimaneggiò
le sue strutture, ma del nuovo rifacimento nulla rimane,
a parte la Cappella di Santa Barbara. Cinque imponenti
torri di piperno e tufo ne delimitano le spesse mura;
il notevole arco di trionfo in marmo, fra le torri
di Mezzo e di Guardia, fu costruito alla metà
del Quattrocento da Francesco Laurana e celebra l'entrata
di Alfonso I d'Aragona in Napoli il 26 febbraio 1443.
La monumentale Sala dei Baroni, che oggi ospita le
riunioni del Consiglio comunale, era la sala centrale
del castello. Fu così chiamata perché
nel 1487 vi furono arrestati i baroni che congiurarono
contro Ferrante I d'Aragona, ivi riuniti dal sovrano
per celebrare le nozze della nipote. Oggi l'edificio
ospita l'omonimo Museo Civico. Nella sua Sala centrale,
Pietro da Morrone, salito al Soglio come Celestino
V, nel dicembre 1294 -come ricorda Dante - «fece
per viltade il gran rifiuto» aprendo la strada
all'ascesa di Bonifacio VIII, dopo un conclave tenutosi
nello stesso locale.
EDIFICI
RELIGIOSI
 Le numerose catacombe cristiane che sorsero fuori
le mura, testimoniano sì l'arte, la storia
e l'architettura della primissima Napoli cristiana,
ma rappresentano anche l'inizio di un'accentuata fede
nella nuova dottrina, che per secoli ha caratterizzato
la vita socio-religiosa della città; allo stesso
modo può essere valutato l'eccessivo numero
di luoghi sacri (tra basiliche, chiese, monasteri,
ritiri, conventi, ecc..). Per spiegare ciò,
vi è da tener conto non solo di questa "predisposizione",
ma anche di fondamentali riferimenti storici.
Le numerose catacombe cristiane che sorsero fuori
le mura, testimoniano sì l'arte, la storia
e l'architettura della primissima Napoli cristiana,
ma rappresentano anche l'inizio di un'accentuata fede
nella nuova dottrina, che per secoli ha caratterizzato
la vita socio-religiosa della città; allo stesso
modo può essere valutato l'eccessivo numero
di luoghi sacri (tra basiliche, chiese, monasteri,
ritiri, conventi, ecc..). Per spiegare ciò,
vi è da tener conto non solo di questa "predisposizione",
ma anche di fondamentali riferimenti storici.
Nel
medioevo il popolo fu influenzato dai pellegrinaggi
in terra santa: i pellegrini che erano di ritorno
da Gerusalemme, spesso approdavano a Napoli, in quanto
il suo porto rappresentava uno dei principali punti
di rientro nel vecchio continente. Più tardi,
a Napoli regnarono Angioini ed Aragonesi (dinastie
anch'esse cristiane che diedero maggior credito alla
già latente devozione al cattolicesimo); per
i secoli successivi la città fu ancora saldamente
nel campo della controriforma, direttamente sotto
il dominio degli Asburgo di Spagna.
Questi,
dunque, furono tra i principali motivi che forgiarono
l'etica religiosa della città e giustificano
le numerose costruzioni di edifici di culto: nel XVIII
secolo Napoli raggiunse il numero record di 100 fra
conventi e monasteri, e 500 chiese, tanto che le valse
il soprannome di città dalle 500 cupole. In
epoca più moderna, il periodo del Risanamento,
i terremoti e soprattutto i 181 bombardamenti della
seconda guerra mondiale, hanno sottratto alla città
partenopea più di 60 chiese; ma, nonostante
tutto, Napoli continua a possedere il maggior numero
al mondo, di chiese, di conventi ed altre strutture
di culto. Anche se siconsiderano solo le chiese storiche,
il numero è particolarmente elevato; esse raggiungono
infatti le 448 unità.
 Molte
sono le chiese proibite, dalle porte sbarrate da secoli
o abbandonate senza custode ma che spesso contengono
anche opere di alto valore artistico (come ad esempio
la chiesa di Santa Maria della Sapienza su Via Costantinopoli
che contiene tele di Luca Giordano ed un ricco interno
barocco). Le chiese napoletane sono testimonianze
artistiche, storiche ed architettoniche formatisi
nell'arco di diciassette secoli; ad esse, seppur in
maniera indiretta, sono legate per lo più le
vicende artistiche ed architettoniche della città,
nonché i suoi repentini cambiamenti.
Molte
sono le chiese proibite, dalle porte sbarrate da secoli
o abbandonate senza custode ma che spesso contengono
anche opere di alto valore artistico (come ad esempio
la chiesa di Santa Maria della Sapienza su Via Costantinopoli
che contiene tele di Luca Giordano ed un ricco interno
barocco). Le chiese napoletane sono testimonianze
artistiche, storiche ed architettoniche formatisi
nell'arco di diciassette secoli; ad esse, seppur in
maniera indiretta, sono legate per lo più le
vicende artistiche ed architettoniche della città,
nonché i suoi repentini cambiamenti.
Le
prime chiese cristiane, a Napoli, risalgono a poco
dopo l'editto di tolleranza costantiniano di Milano
del 313. In città vi si trovano differenti
tipi di "tracce" paleocristiane, le più
eclatanti sono: quelle in cui resti absidali, affreschi
e quant'altro, sono spesso locati negli ipogei delle
ben più recenti chiese barocche e/o rinascimentali;
oppure, quelle in cui l'architettura paleocristiana
si è fusa con le successive correnti artistiche
(un mescolamento che ha poi dato vita a delle vere
e proprie chiese "ibride"). Tuttavia, esempi
di chiese paleocristiane "pure" e/o pressoché
integre, sono riscontrabili invece in alcune catacombe.
Tra le più antiche chiese paleocristiane vi
è sicuramente la basilica di San Pietro ad
Aram; l'edificio, seppur rimaneggiato secondo altri
stilemi, possiede ancora marcate origini paleocristiane,
come testimoniato soprattutto dai suoi grandi sotterranei
che hanno conservato rigorosamente arte ed architettura
paleocristiana. Molto simile al caso precedente è
la chiesa di San Giorgio Maggiore che possiede al
suo interno, un raro esempio di abside antica completa.
Per
quanto riguarda le chiese gotiche ricordiamo la basilica
di Santa Chiara che con il suo elegante gotico provenzale
e la sua navata lunga circa 130 metri edalta 45, è
la maggiore opera gotica cittadina: al suo interno,
inoltre, vi sono vari monumenti sepolcrali di varie
dinastie o famiglie nobiliari dell'epoca oltre ad
altri riferimenti artistichi e/o architettonici. Altro
punto di riferimento è la chiesa di San Domenico
Maggiore, eretta secondo i classici canoni del gotico;
venne rimaneggiata nel Rinascimento (a causa soprattutto
dei terremoti e incendi che imperversarono in questo
periodo), successivamente, fu rimaneggiata anche secondo
gli stilemi del barocco. Altro esempio gotico è
la San Pietro a Majella, la cui struttura ha conservato
l'aspetto sfoglio originario, ad eccezione del soffitto
barocco. La chiesa di San Lorenzo Maggiore, invece,
rappresenta una pregevole mescolanza in stile gotico
francese con quello francescano; anch'essa, subì
poi dei ritocchi barocchi.
Il
Rinascimento si impose grazie alla presenza di Alfonso
d'Aragona, il quale trasformò Napoli in una
delle principali città rinascimentali del tempo.
In realtà i legami artistici e culturali con
Firenze avevano già prodotto un parziale mutamento
nel contesto architettonico della città; lo
dimostra soprattutto la chiesa del Gesù Nuovo
che con la sua classica facciata a punta di diamante,
rispecchia i primi esempi e/o elementi rinascimentali
della città. Altro esempio rilevante di questa
corrente è Sant'Anna dei Lombardi che attraverso
le sue grandi cappelle a pianta centrale fa intuire
chiaramente come sia stata influenzata dalle analoghe
costruzioni fiorentine. Con l'avvento del manierismo,
infine, il rinascimento a Napoli è in piena
caduta ma ciò nonostante, l'ultimo cinquantennio
produce la notevole chiesa rinascimentale di Santa
Maria la Nova.
 Le
chiese monumentali di Napoli si presentano per lo
più sotto una veste barocca, ciò è
dovuto grazie alla presenza diretta di Caravaggio;
egli provocò unostravolgimento nel panorama
artistico ed architettonico di Napoli, influenzando
intere schiere di urbanisti, architetti, pittori napoletani
dell'epoca che, di lì a poco, avrebbero trasformato
Napoli in una vera e propria città "barocca".
Le
chiese monumentali di Napoli si presentano per lo
più sotto una veste barocca, ciò è
dovuto grazie alla presenza diretta di Caravaggio;
egli provocò unostravolgimento nel panorama
artistico ed architettonico di Napoli, influenzando
intere schiere di urbanisti, architetti, pittori napoletani
dell'epoca che, di lì a poco, avrebbero trasformato
Napoli in una vera e propria città "barocca".
La
certosa di San Martino, tra i maggiori complessi monumentali
e religiosi di Napoli, costituisce in assoluto, uno
dei maggiori esempi di questa corrente. Un'altro importante
esempio barocco della città e non, è
la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro della
cattedrale di Napoli: uno dei gioielli universali
dell’arte, ricca di marmi, affreschi, dipinti
e altre opere d’arte dei migliori artisti dell’epoca
è sicuramente uno dei monumenti più
importanti del barocco napoletano seicentesco, per
l’insieme di decorazioni che videro la partecipazione
di artisti di eccezionale levatura.
Tra
le più "recenti" chiese monumentali
della città, vi sono quelle partorite dal neoclassicismo;
queste, si possono dividere in due categorie distinte,
ovvero: nella prima, appartengono le chiese che sono
ancora vicine al tardo barocco napoletano, conservando
ancora un'impronta tipica di quest'ultimo periodo;
mentre, nella seconda tipologia appartengono le chiese
caratterizzate da interni e/o da facciate severe,
che preludono al neoclassico puro. La maggiore opera
inerente a questo periodo, nonché uno dei monumenti
più celebri della città è la
basilica di San Francesco di Paola realizzata da Pietro
Bianchi, il quale mostrò nella realizzazione
della nuova chiesa grandi qualità ingegneristiche,
attestate dalla solidità dell'opera e dall'intelligenza
delle soluzioni tecniche
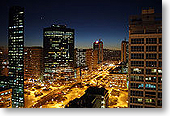 MUSICA
MUSICA
La vita musicale napoletana fu molto intensa già
a partire dal XV fino al XVII secolo nell'ambito della
polifonia sacra e profana. Dal XVII e soprattutto
nel XVIII secolo la Scuola Musicale Napoletana assunse
un ruolo preminente nel campo della musica sacra e
operistica con musicisti come Alessandro Scarlatti,
Giovan Battista Pergolesi, Nicola Porpora.L'intero
patrimonio del '700 musicale napoletano e quasi del
tutto inedito, oltre 150 biblioteche nel mondo ne
conservano i manoscritti,*L'Istituto Internazionale
per lo studio del '700 musicale napoletano,si occupa
di ricercare, studiare e diffondere la musica della
scuola napoletana del '700. Tra i maggiori esperti
della musica napoletana del '700 vanno ricordati due
napoletani doc il grande Roberto De Simone, ed Enzo
Amato che ha riportato alla luce innumerevoli capolavori
della suddetta scuola tra cui la Sinfonia Venezia
di Pasquale Anfossi da cui si evince un clamoroso
plagio Mozartiano.
La
canzone classica napoletana, assurta a fenomeno storico
nel corso delle annuali feste di Piedigrotta tra l'Ottocento
e la prima metà del Novecento e con i successivi
Festival della Canzone Napoletana, è oggi un
patrimonio tutelato. È attivo da vari anni,
presso la sede RAI di Napoli, l'Archivio Sonoro della
Canzone Napoletana. Altro fenomeno musicale di particolare
interesse è la cosiddetta Sceneggiata che si
fonda sulla sceneggiatura di un intero spettacolo
teatrale partendo da una canzone di argomento popolare,
protagonista indiscusso di quest'arte fu Mario Merola.
 La
vita musicale napoletana fu molto intensa già
a partire dal XV fino al XVII secolo nell'ambito della
polifonia sacra e profana. Dal XVII e soprattutto
nel XVIII secolo la Scuola Musicale Napoletana assunse
un ruolo preminente nel campo della musica sacra e
operistica con musicisti come Alessandro Scarlatti,
Giovan Battista Pergolesi, Nicola Porpora.L'intero
patrimonio del '700 musicale napoletano e quasi del
tutto inedito, oltre 150 biblioteche nel mondo ne
conservano i manoscritti,*L'Istituto Internazionale
per lo studio del '700 musicale napoletano,si occupa
di ricercare, studiare e diffondere la musica della
scuola napoletana del '700. Tra i maggiori esperti
della musica napoletana del '700 vanno ricordati due
napoletani doc il grande Roberto De Simone, ed Enzo
Amato che ha riportato alla luce innumerevoli capolavori
della suddetta scuola tra cui la Sinfonia Venezia
di Pasquale Anfossi da cui si evince un clamoroso
plagio Mozartiano.
La
vita musicale napoletana fu molto intensa già
a partire dal XV fino al XVII secolo nell'ambito della
polifonia sacra e profana. Dal XVII e soprattutto
nel XVIII secolo la Scuola Musicale Napoletana assunse
un ruolo preminente nel campo della musica sacra e
operistica con musicisti come Alessandro Scarlatti,
Giovan Battista Pergolesi, Nicola Porpora.L'intero
patrimonio del '700 musicale napoletano e quasi del
tutto inedito, oltre 150 biblioteche nel mondo ne
conservano i manoscritti,*L'Istituto Internazionale
per lo studio del '700 musicale napoletano,si occupa
di ricercare, studiare e diffondere la musica della
scuola napoletana del '700. Tra i maggiori esperti
della musica napoletana del '700 vanno ricordati due
napoletani doc il grande Roberto De Simone, ed Enzo
Amato che ha riportato alla luce innumerevoli capolavori
della suddetta scuola tra cui la Sinfonia Venezia
di Pasquale Anfossi da cui si evince un clamoroso
plagio Mozartiano.
La
canzone classica napoletana, assurta a fenomeno storico
nel corso delle annuali feste di Piedigrotta tra l'Ottocento
e la prima metà del Novecento e con i successivi
Festival della Canzone Napoletana, è oggi un
patrimonio tutelato. È attivo da vari anni,
presso la sede RAI di Napoli, l'Archivio Sonoro della
Canzone Napoletana. Altro fenomeno musicale di particolare
interesse è la cosiddetta Sceneggiata che si
fonda sulla sceneggiatura di un intero spettacolo
teatrale partendo da una canzone di argomento popolare,
protagonista indiscusso di quest'arte fu Mario Merola.
TEATRO
Il teatro napoletano è una delle più
antiche e conosciute tradizioni artistiche della città.
Tra i suoi principali esponenti si citano Antonio
Petito, Raffaele Viviani, Roberto Bracco, Eduardo
Scarpetta, Eduardo De Filippo e la sua compagnia composta
fra l'altro dai fratelli Titina De Filippo e Peppino
De Filippo, questi ultimi a loro volta autori teatrali.
Eduardo
intraprese una originale attività di scrittura
e recitazione teatrale, volta a portare sul palcoscenico
l'anima di Napoli e dei suoi abitanti, la napoletanità
considerata come cartina di tornasole, attraverso
cui evidenziare i caratteri fondamentali dell'umanità
e della società contemporanea. Tra le sue commedie
più importanti ricordiamo Napoli milionaria!,
Il sindaco del rione Sanità, Natale in casa
Cupiello, Filumena Marturano, Uomo e galantuomo e
Questi fantasmi! (tra l'altro riportata con successo
sui palcoscenici di New York nel 2004, dall'attore
e regista cinematografico John Turturro).
 Tra
gli autori contemporanei ricordiamo Roberto De Simone
e Annibale Ruccello, prematuramente scomparso, cui
si devono i drammi Le cinque rose di Jennifer e Ferdinando,
il trio comico cabarettistico de La Smorfia composto
da Enzo Decaro, Lello Arena e Massimo Troisi (quest'ultimo
anche regista e sceneggiatore). Spicca inoltre il
nome di Vincenzo Salemme, tra i suoi scritti Lo strano
caso di Felice C., ...E fuori nevica e Premiata Pasticceria
Bellavista. Tradizionale maschera napoletana è
inoltre la figura di Pulcinella, che, secondo Benedetto
Croce, nacque nella Napoli del Seicento da un certo
Puccio d'Aniello.
Tra
gli autori contemporanei ricordiamo Roberto De Simone
e Annibale Ruccello, prematuramente scomparso, cui
si devono i drammi Le cinque rose di Jennifer e Ferdinando,
il trio comico cabarettistico de La Smorfia composto
da Enzo Decaro, Lello Arena e Massimo Troisi (quest'ultimo
anche regista e sceneggiatore). Spicca inoltre il
nome di Vincenzo Salemme, tra i suoi scritti Lo strano
caso di Felice C., ...E fuori nevica e Premiata Pasticceria
Bellavista. Tradizionale maschera napoletana è
inoltre la figura di Pulcinella, che, secondo Benedetto
Croce, nacque nella Napoli del Seicento da un certo
Puccio d'Aniello.
Il
teatro massimo della citta è il Teatro di San
Carlo (il più capiente d'Italia con 3.000 posti
ed il più antico d'Europa in attività),
mentre il teatro stabile della città è
il Teatro Mercadante. Altri noti palcoscenici sono
il Diana, il San Ferdinando, l'Augusteo, il Sannazaro,
il Bracco, il Bellini.
Grazie
a questa secolare e duratura tradizione teatrale e
al numero da record di teatri rispetto alle altre
città italiane, la città di Napoli è
stata scelta dal governo come sede delle prime tre
edizioni del Festival Nazionale del Teatro che si
terrà nel triennio 2007-2009.
GASTRONOMIA
La pizza, prodotto culinario napoletano per eccellenza,
si diffonde in città tra il Seicento e il Settecento
senza avere tuttavia le caratteristiche attuali. Si
tratta infatti inizialmente di una variante della
focaccia, arricchita con basilico o strutto o alici
e più tardi con pomodoro e mozzarella di bufala
campana o fior di latte. Solo nell'Ottocento inizia
la moda dei buongustai di pizza e la prima vera pizzeria
della quale si conosce il nome fu aperta nel 1830
nella zona di Port'Alba. La ricetta classica più
nota risale invece al 1889. L'Associazione "Verace
Pizza Napoletana" fondata nel 1984 dai più
antichi maestri pizzaioli diffonde d'allora la metodologia
di produzione e degustazione della verace pizza napoletana
artigianale, associando le pizzerie nel mondo che
utilizzano i prodotti previsti e la corretta metodologia.
Ogni anno a Napoli a settembre si svolge il Pizzafest
nella sede della Mostra d'Oltremare dove si può
degustare una pizza scegliendo tra le dozzine di pizzerie
all'aperto.
 La
pastasciutta
La
pastasciutta
Non si ferma certo alla pizza il vasto campionario
della cucina napoletana. Necessario citare infatti
almeno gli spaghetti: l'immagine tipica dell'affamato
Pulcinella che s'ingozza con un piatto di spaghetti
al pomodoro è tipica dell'iconografia napoletana,
ed è stata ripresa anche da Totò nel
suo Miseria e nobiltà. Tra i modi più
tipici di cucinare gli spaghetti (o anche vermicelli)
a Napoli vi è quello di condirli con le vongole.
Gli spaghetti alle vongole possono essere o in bianco
o col pomodoro e possono essere conditi o con vongole
veraci o con lupini. Altra tradizione è quella
del ragù, tipico piatto domenicale. Probabilmente
derivante dal ragôut francese, il ragù
napoletano (o rraù in dialetto, celebrato in
una poesia di De Filippo) è una salsa di lunga
ed elaborata preparazione (cinque-sei ore di cottura)
fatta con pomodoro e carne di vitello o di maiale,
soprattutto nel periodo di Carnevale, e va servita
su pasta col buco, in particolare i tradizionali ziti.
I
dolci
Celeberrima è anche la tradizione dolciaria
napoletana, che ha beneficiato degli influssi delle
diverse corti (e rispettivi cuochi ufficiali) che
si sono succedute nella città. Tra le diverse
specialità la più nota è probabilmente
la sfogliatella, che può essere "riccia"
o "frolla" a seconda della preparazione
della pasta sfoglia che la compone: realizzata nel
Settecento nel monastero di Santa Rosa situato a Conca
dei Marini, nei pressi di Amalfi, il ripieno è
a base di crema di ricotta, semolino, vaniglia, cedro
scorzette di arancia candite. Vi è poi il babà,
forse di origini polacche, dolcetto fatto con pasta
morbida imbevuto di sciroppo a base di limone e rum
e che poi può essere ricoperto in superficie
con crema pasticciera e frutta fresca. Le zeppole
mangiate il giorno di San Giuseppe - e che per questo
a volte sono confuse con le zeppole di San Giuseppe
(bignè alla crema) - sono a Napoli morbide
ciambelline ricoperte di zucchero candito.
Ci
sono poi dolci legati a festività, come la
pastiera che si mangia a Pasqua, fatta con pasta frolla
e grano cotto nonché con ricotta, cedro, arancia
e zucca candita. A Natale ci sono gli struffoli, piccole
sferette fritte ricoperte di diavolilli (confettini
colorati), canditi e miele, che si suppone siano stati
portati dagli antichi greci (stroungolous è
una parola che significa arrotondato). A Carnevale,
infine, ci sono le chiacchiere, fritte e ricoperte
di zucchero a velo, il migliaccio, fatto con semola,
latte e ricotta, ed infine il sanguinaccio, crema
in origine fatta di sangue di maiale e oggi di cioccolata
aromatizzata con la cannella.
IL
PRESEPE
Sebbene la leggenda ritenga che il primo presepe fu
realizzato da Francesco d'Assisi nel 1223, questa
tradizione è tipicamente napoletana. Tra il
XVII e XVIII secolo l'arte del presepe raggiunge le
più alte punte artistiche. Molti esemplari
sono visibili oggi nel Museo di San Martino. La tradizione
è ancora viva per molti napoletani che allestiscono
il presepe nelle loro case nel periodo natalizio,
acquistando le statuette nella celebre Via San Gregorio
Armeno dove si trovano le botteghe dei pastorai.
